
A funny game: il cinema post-moderno e altri enigmi
“…perché in realtà non state davvero guardando.
Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati”
La rinascita dell’ornamento e la morte della narrazione
Il post-moderno. “Chi era costui?”, direbbe Don Abbondio. La domanda, per quanto telegrafica, non è banale, e dato che le domande sono più importanti delle risposte, siamo già a metà dell’opera.
Il termine nasce in architettura, dove i progettisti post-moderni hanno ingaggiato un duello cappa e squadra con le forme essenziali e minimaliste dei razionalisti. Questi ultimi avevano realizzato delle costruzioni lineari e semplici, prive di decorazioni (ritenute superflue) e soprattutto slegate dai richiami del passato.

Tuttavia, dato che la storia, a differenza di quanto pensato da Francis Fukuyama, non raggiunge mai un esito definitivo, non si assesta mai, ma continua a vorticare indomita, ai modernisti sono succeduti i post-moderni, che hanno riportato in voga i collegamenti con le architetture del passato, ed hanno riavviato l’utilizzo dell’ornamento. Una tendenza sintetizzata da una famosa frase di Robert Sterne:
“L’ornamento non è un delitto, gli edifici ispirati ad altri edifici della storia sono più significativi di quelli che non vi si ispirano.”
L’uso del termine si è poi allargato a macchia d’olio, andando a toccare varie zone della mappa artistica (e non solo).
In letteratura il tipico romanzo post-moderno è caratterizzato dall’idea secondo la quale tutto ciò che poteva essere narrato è già stato narrato (considerazione già di per se ambigua, se pensiamo che il post-moderno altro non è che la narrazione della fine delle narrazioni, che quindi non sono veramente morte).
In un contesto tale, come potevano gli autori degli anni 60 e 70 dare nuova linfa alla materia artistica? La scrittura ha iniziato a ripiegarsi su se stessa, a trattare di se stessa. Facciamo l’esempio del racconto breve “Perso nella casa stregata” di John Barth, dove l’autore antepone ad una descrizione dei personaggi della storia il seguente periodo:

“Uno dei numerosi metodi tradizionalmente usati dagli scrittori per caratterizzare i personaggi è descrivere l’aspetto fisico e i modi di fare. È anche importante tenere in funzione i sensi.”
Un intento, dunque, votato alla riflessione sul mezzo stesso (in questo caso lo scrivere) e alla decostruzione delle regole che fino a quel momento avevano strutturato le storie narrate.
Altri temi ricorrenti, che si affiancano a quello della decostruzione, riguardano la confusione di stili e di generi e l’ampio uso di un’ironia multidirezionale.
Watch a few movies, take a few notes
E il cinema post-moderno? Condivide con la letteratura dello stesso genere (da Pynchon a Wallace) la tendenza alla riflessione sul medium e quella al collage. L’anelito è dunque lo stesso, ma, per raggiungere lo scopo sperato, si confà di un maggiore utilizzo di citazioni.
La cinematografia post-moderna è infatti caratterizzata da un citazionismo senza limitismo. Fulgido esempio di ciò è rappresentato dalle opere di Quentin Tarantino, che spaziano dal manga giapponese agli spaghetti western, o da quelle di Woody Allen.

Il regista newyorkese, vero patrimonializzatore della storia, cita in continuazione: in Ombre e Nebbia rivisita Fritz Lang, in Stardust Memories riecheggia Fellini, in Settembre ripropone Bergman.
Ovviamente, ciò che fa di Allen un titano della settima arte è la sua capacità di modellare le citazioni col suo personalissimo stile (un vero marchio d’arte, come i forchettoni di Capogrossi o i tagli di Fontana), fatto di un’ironia colta e nichilista (ma mai sarcastica), animata dalle sue divertentissime ossessioni ipocondriache.
“Abbiamo guardato un paio di film, e preso un paio di appunti” cantilena l’assassino in Scream, il conosciutissimo horror iper-citazionista di Wes Craven, che, con un fare tremendamente meta-cinematografico, porta alla luce le regole del genere slasher per poi sovvertirle consapevolmente.
“Ora non sei più vergine, ora devi morire”, continua il pazzo, riferendosi alla tendenza (quasi un imperativo categorico) degli scary movie a stelle e strisce di far scampare al massacro solo la fanciulla vergine, in un basilare simbolismo riguardante la perdita dell’innocenza tipica del passaggio all’età adulta.
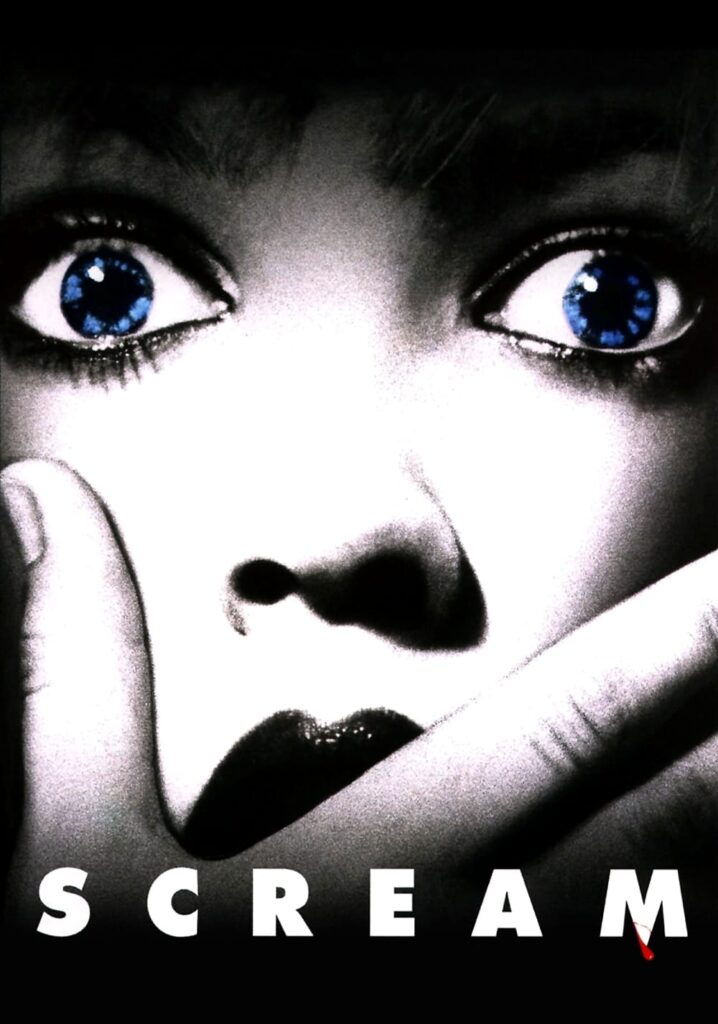
Dato che le trasfigurazioni dei serial killer mi sembrano molto adatte per rappresentare la corrente post-moderna, rimango in argomento, introducendo Funny Games di Michael Haneke.
Leggendo la sinossi di quest’ultima opera sembrerebbe di trovarsi di fronte all’ennesimo home invasion a tinte splatter:
“Come ogni anno, quando arriva il periodo delle vacanze, Anna e George partono alla volta della loro tranquilla casa sul lago… …La famiglia riceve però l’inaspettata visita di due ragazzi che, con un banale pretesto, riescono ad entrare in casa e trasformare la loro vacanza in un terribile incubo.”
Dove sta l’inghippo? Sta nel fatto che Funny Games (un nome che è tutto un programma) è un film cosciente di essere un film. Non solo, si rivela allo sguardo dello spettatore per quello che è: un artefatto, un costrutto, una messa in scena, una finzione strutturata da regole precise e ricorrenti, che questa volta verranno sovvertite.
I due protagonisti, infatti, rompono costantemente la quarta parete: quel limite invalicabile (perché invisibile) che separa il mondo reale dello spettatore (fatto di poco salutari pop-corn al burro e telefonini che squillano in continuazione) da quello degli eventi narranti, che è, come dicevamo, falso (o forse no…).
Quando la quarta parete viene frantumata, quando le sue schegge taglienti si mostrano allo sguardo (perverso) dello spettatore, la sospensione dell’incredulità, cioè la capacità che possediamo di “dimenticarci” che ciò che stiamo vedendo sia privo di realtà ontologica, viene cancellata repentinamente, e gli ingranaggi del film si fanno visibili.
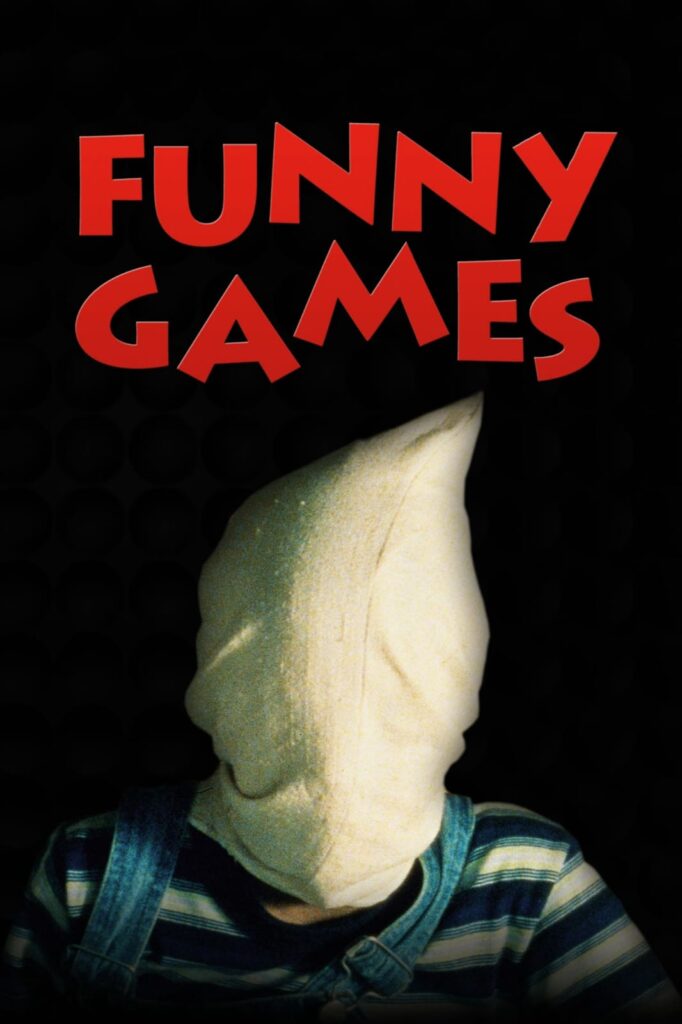
Ovviamente, a meno che tu non sia un matto da legare, non potrai mai dimenticarti del tutto che, ad esempio, Jack è un attore che sta solo fingendo di avere una strana storia d’amore con una snob annoiata, ma riesci a farlo quanto basta per “entrare nella storia” e goderne appieno.
Dunque, come fanno i due bischeri di Haneke a rompere la quarta parete? Semplice: guardano verso la cinepresa, rivolgendosi direttamente allo spettatore, comunicandogli che sta volta non ci sarà nessuno sviluppo di trama, che la famiglia non riuscirà a liberarsi e fuggire, che sta volta moriranno tutti e basta. E in effetti così accade: i membri della famiglia vengono tolti di mezzo uno dopo l’altro, peraltro con modalità del tutto prive di pathos.
Uno dei momenti più brutalmente decostruzionisti avviene quando la moglie, liberatasi dalle funi che la legavano, afferra un fucile e spiattella uno dei due ragazzi. Ma un film che è consapevole di essere un film non va al tappeto nemmeno in una situazione simile, e infatti il killer sopravvissuto, usando un telecomando poggiato sul sofà, riesce a riavvolgere la scena (esatto, quella dell’opera di finzione che noi stiamo guardando, nella quale lui dovrebbe essere un semplice personaggio), per poi spostare l’arma fuori dal raggio d’azione della donna, che prova a raggiungerla invano.
“È solo un gioco, un gioco divertente”, gongola Michael Pitt (che è molto più bravo del più noto collega dallo stesso cognome), ma questo gioco presuppone una consapevolezza assoluta sul mezzo, e la volontà di trasfigurarne la struttura a proprio piacimento.

Le citazioni, il revival, la commistione di stili e di generi, la meta-cognizione, la presa di distanza ironica e critica: tutto questo marasma ha l’unico scopo di scandagliare una materia trita e ritrita (e ormai stanca), vivisezionarla e poi elettrificarla alla maniera delle rane di Galvani. Infondere nuova linfa, assemblare un novello Frankenstein, carico di energie giovani (e intenti per lo più malevoli). “Prendi vita!”, griderebbe invasato Gene Wilder, che infatti è un altro ironicissimo autore votato alla destrutturazione.
In principio era il verbo (cioè il mezzo)

Come tirare le somme? Di fronte al tribunale della ragione, che verdetto ottiene lo sforzo post-moderno? Come giudicare questo continuo overthinking, questo continuo rimuginare? Esso ha lati catartici oppure aliena da ciò a cui dovrebbe tendere ogni sforzo artistico, cioè alla vita? Alcuni propendono per la seconda ipotesi (“levati e lasciami guardare il film” diceva Risi a Moretti, una sorta di Allen all’italiana interessato a confondere l’autore della pellicola con il protagonista della stessa).
Il sottoscritto invece dà un’assoluzione totale (per quello che vale, cioè nisba), e nel farlo, oltre a ricordare che oggi la decostruzione è una necessità inevitabile che accomuna tantissimi artisti, (da Lars von Trier a Seth MacFarlane, passando per Bansky) riporta le parole del regista sperimentale Morgan Menegazzo, intervistato da Francesco Cazzin:
“Nel creare storie abbiamo perso la nostra storia, che è anche la storia del mezzo. È grazie al mezzo che possono esistere queste storie, e queste storie dipendono dal mezzo.”
Nel cinema (come in tutte le altre arti, anche in quelle che scoprono meno il fianco alla commercializzazione) tutto parte dal mezzo (cioè dalla luce che è catturata dalla pellicola, ma questa è un’altra storia). Il medium è ab ovo, è il big bang. E’ presente, e lo spettatore “deve viverlo, odorarne la presenza”.

Decostruire e riflettere sul mezzo ci può permettere di prendere consapevolezza, di controllare le redini del flusso gigantesco e incontrollato delle immagini (specie quelle pubblicitarie), le quali, vettori infiniti e unidirezionali, rischierebbero di sovrastarci, di schiacciarci, di sommergerci.
Poco importa che il post-moderno sia sempre in procinto di tramutarsi in arido nozionismo e spocchioso accademismo (per de-territorializzare devi avere una conoscenza assoluta del territorio, come dimostrano le citazioni e il revival). È un rischio che dobbiamo correre, per mantenere il nostro senso critico nella società dell’informazione caotica e veloce nella quale siamo gettati.
Alessandro Gaetani
